Il processo di socializzazione
Poiché una cultura stabilisce ciò che è «buono» e ciò che è «cattivo», ciò che è «giusto» e ciò che è «sbagliato», è normale che essa cerchi di trasmettere questa visione del mondo alla generazione più giovane. Questo sforzo di trasmettere i valori di una cultura ai membri più giovani della società è chiamato «processo di socializzazione». Dal punto di vista della persona ricevente, la socializzazione è il processo attraverso il quale essa «interiorizza» e adotta la visione del mondo, i valori e le norme di una data cultura. Il processo di socializzazione, nella sua «naturalità» presenta ovviamente risvolti ambigui: può tradursi da parte dei ragazzi e dei giovani in una passiva accettazione (stimolata da opportuni «premi» e «punizioni») della cultura dominante in cui possono convivere ideali diversi, non tutti positivamente orientati verso la comprensione degli altri.
Sul processo di socializzazione si può quindi innestare una dinamica più propriamente educativa, ossia un rapporto tra adulti e ragazzi volto a stimolare la capacità critica di questi ultimi: se visono adulti disponibili a ciò si possono fornire ai ragazzi e ai giovani esperienze e strumenti per valutare appunto criticamente la cultura dominante e per formarsi quindi un'idea autonoma che conduce ad uno sviluppo, anche magari verso direzioni nuove, della cultura stessa.
Si tratta quindi di introdurre all'interno di un processo di socializzazione «naturale» gli stimoli educativi per il superamento dei limiti della propria cultura e per imparare quindi a giudicare gli altri sapendo «relativizzare» il proprio punto di vista.
Etnocentrismo e sue conseguenze
Come abbiamo già detto, quando si giudica un'altra cultura, l'uomo ha la naturale tendenza a giudicarla sulla base dei criteri della sua propria visione del mondo. Questo viene detto etnocentrismo. Nel senso più stretto della parola, l'etnocentrismo implica pure una tendenza a credere la propria cultura superiore alle altre e a giudicare le altre culture attraverso le norme stabilite da questa.
Il bisogno di sviluppare una «sensibilità culturale»
Abbiamo già visto che, tramite la cultura, un essere umano acquisisce un'identità culturale. Abbiamo anche visto che, proprio come un individuo non può viveri in completo isolamento dal mondo che lo circonda, così neppure una cultura può vivere in completo isolamento.Allo stesso modo in cui l'identità culturale di un uomo si arricchisce nel contatto con altri uomini, così anche l'identità culturale dei popoli si arricchisce nel contatto con le tradizioni e i valori di altri popoli. Questo è vero specialmente per l'uomo d'oggi, che allarga costantemente i suoi orizzonti. È diventato perciò un cliché dire che viviamo in un mondo che s restringe. Possiamo spostarci ad una velocità tale che ci permette di entrare in contatto con altri molto più rapidamente. Il telefono ci permette di essere in contatto con una larga parte del mondo, come se si trattasse di una chiamata locale. Inoltre, per mezzo dei mass media (giornali, radio, TV, ecc.) il mondo è alla nostra portata ogni giorno, anzi ogni minuto. Coi nostri orizzonti si allargano continuamente e vanno oltre il nostro «villaggio», fino al «villaggio globale» come lo chiamava Marshall McLuhan. Tuttavia, per quanto noi possiamo essere ben informati (e a volte qualcuno potrebbe sostenere, «super informati») nella maggioranza dei casi siamo informati solo di ciò che si riferisce ad avvenimenti episodici e accidentali. Un terremoto, un tifone, un colpo di stato, sequestri di ostaggi, un incidente terribile o dei seri tumulti fanno notizia in prima pagina e vengono anche riferiti alla televisione e alla radio.
Non veniamo altrettanto informati, ed ancor meno sensibilizzati, sull'«anima interiore» di un popolo, sulle caratteristiche preminenti della sua storia, delle sue tradizioni e della sua cultura. Senza che ne siamo coscienti, ciò può portare a dare giudizi affrettati e sconsiderati che possono essere anche ingiusti e scorretti.
È ovvio che anche un grande storico o un antropologo erudito non possono conoscere tutte le società che esistono e le loro rispettive culture. C'è tuttavia qualcosa che noi tutti possiamo fare: sviluppare una «coscienza culturale» che ci aiuti a non giudicare le altre culture secondo le nostre premesse culturali. Questo è un atteggiamento mentale che deriva allo stesso tempo dal rispetto degli altri e dalla onestà intellettuale: può e deve venir coltivato e sviluppato ogni giorno.
Quattro idee chiave come abbiamo prima accennato possono servire da base su cui sviluppare questo atteggiamento. Vale certamente la pena di ripeterle:
1. Ogni cultura forma un tutto coerente; esso costituisce un «insieme di significati».
2. Di conseguenza nulla è «arbitrario» in una cultura, ogni cosa è in relazione ad una causa precisa. Anche un'abitudine che a prima vista sembra «strana», «ridicola», «aberrante» o «barbara» per noi, ha un'origine, una ragione d'essere e trova il suo significato ponendola nel suo sistema culturale.
3. Benché ogni cultura sia un tutto coerente, essa non è tuttavia una entità statica. Le culture sono dinamiche, si muovono. Così un cambiamento introdotto in uno degli elementi dell'insieme produrrà dei cambiamenti in tutti gli altri elementi. Un cambiamento in un metodo di produzione o l'introduzione di una nuova tecnologia avrà inevitabilmente delle ripercussioni sullo stile di vita, sui modelli di lavoro, la divisione di lavoro tra i sessi, il cibo e l'igiene, la casa e il matrimonio, ecc. Dovremmo perciò diffidare da giudizi semplicistici e sviluppare un istinto che ci guidi ad esaminare ogni «elemento culturale» come parte di un insieme che non è solo «complesso», ma anche «dinamico».
4. Infine, il punto senza dubbio più importante: si può stabilire un vero «dialogo» nel senso più stretto della parola, uno scambio, una condivisione tra i popoli di culture differenti se ogni persona considera «gli altri» e la gente di altre culture non come esseri «strani», «buffi» o «incomprensibili», ma come persone appartenenti ad una società che accoglie valori degni di esser conosciuti, apprezzati e condivisi. È solo a questo prezzo che possono venire in essere nuove specie di relazioni; relazioni che non saranno più basate sulla dominazione o sulla dipendenza, sulla incomprensione o sulla sfiducia, ma sulla stima reciproca e sul rispetto tra i popoli e i Paesi di differenti culture.
Al fine di raggiungere questo risultato, noi tutti dobbiamo essere capaci di prendere una distanza critica dalla nostra cultura, dal nostro sistema di valori, dalle mete della nostra società, dal nostro modello di sviluppo, ecc. In breve dobbiamo imparare a giudicare gli altri secondo le loro premesse culturali e non secondo le nostre.
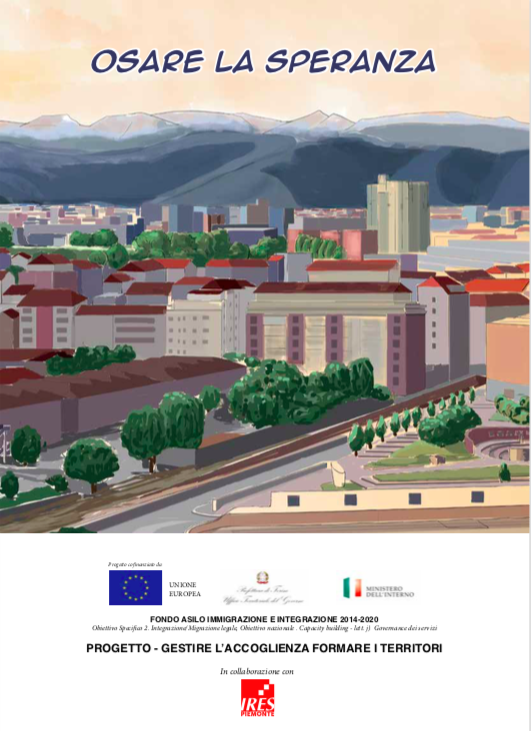 Tre storie a fumetti per raccontare percorsi di vita e di inserimento sociale di richiedenti asilo, ma soprattutto di uomini, donne e bambini giunti in Italia con motivazioni e percorsi diversi e accomunati dallo stesso iter burocratico e dal desiderio di avere un futuro nel nostro Paese. Ciascun racconto è ispirato ad una storia vera e illustra le attività di accoglienza e supporto ai percorsi di integrazione che devono essere garantite secondo i principi costituzionali riportati nella
Tre storie a fumetti per raccontare percorsi di vita e di inserimento sociale di richiedenti asilo, ma soprattutto di uomini, donne e bambini giunti in Italia con motivazioni e percorsi diversi e accomunati dallo stesso iter burocratico e dal desiderio di avere un futuro nel nostro Paese. Ciascun racconto è ispirato ad una storia vera e illustra le attività di accoglienza e supporto ai percorsi di integrazione che devono essere garantite secondo i principi costituzionali riportati nella 





